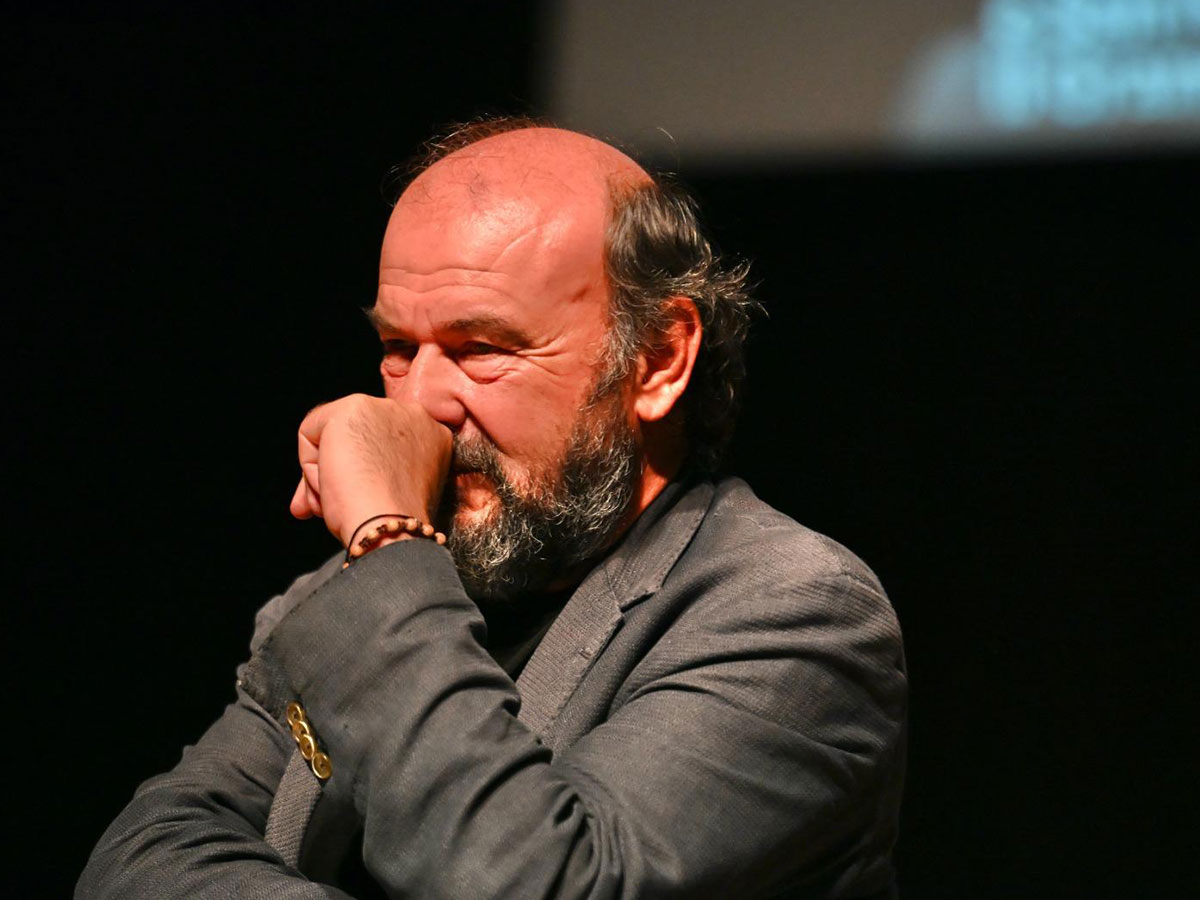Intervento di Chiara Murru (Linguista, Università ECampus) sulla poesia di Davide Rondoni all'interno della rassegna a cura di Michela Silla
Introduzione prima della lettura:
Da L’allodola e il fuoco: «La poesia è quasi niente nell’aria del mondo. […] Mi chiedono a cosa serva la poesia. E come tutti quelli che l’hanno conosciuta non so bene cosa dire […] Eppure le ho dedicato la vita, me l’ha presa. Allora dico piano “Niente”. Niente: splendore di questa parola. Suona vertiginosa quando indica il punto in cui manca ogni convenienza. Ogni economia. Niente scambio. Niente in cambio di niente. […] I bambini e i mistici (e i poeti) sanno cosa è questo “niente” – quello dei pomeriggi dove non si fa niente di importante ma si cresce, o che si sente dentro finché la mamma non ti abbraccia, quello che acceca per un istante la vita che ha visto tutto».
E ora proviamo a vedere insieme come è composto, come è creato questo “niente” con la materia delle parole, con il prodigio della lingua.
Vedremo insieme il lessico, i campi semantici, i suoni e le figure ricorrenti, che si innestano in un tessuto linguistico potente.
Sommario
1. È truccatina – Non ha dottrina – Ti guarda
3. So e non so il punto centrale della rosa, della cosa
4. Rosa notturna che ho esplosa in testa
5. E tu mi aspettavi nel diluvio, occhionda
7. La piccola arpa delle costole
1. È truccatina – Non ha dottrina – Ti guarda
La poesia si apre con una parola all’apparenza semplice ma di forte impatto.
Truccatina: non si trova nei principali strumenti lessicografici. Deriva naturalmente tra truccare > truccata + suffisso diminutivo -ina, e indica l’azione e il risultato del truccarsi. In seguito a una ricerca in rete, sui dizionari e le banche dati e su Google libri, emerge che questa parola è di uso molto recente, e si ritrova adoperata come aggettivo «andai tutta truccatina» e come sostantivo, specialmente riferito alle macchine e alle moto “truccate” («Chi non ha mai dato una truccatina al proprio mezzo?»). Si ritrova infine sui social, in profili legati alla routine di bellezza e alla cura del proprio aspetto («una truccatina e sono pronta per uscire»), mentre è più raro l’utilizzo nei libri: si tratta dunque di un vocabolo raro e afferente al registro informale, colloquiale, famigliare.
Questo si collega bene con le parole seguenti: ninnoli e cordicelle che contribuiscono ad aprire potentemente lo sguardo del lettore (o dell’ascoltatore, come nel nostro caso) su un’immagine di giovinezza, quasi frivolezza.
E infatti, subito dopo
«Dicono: vuoti
questi giovani, strani –
no»
«Dicono vuoti questi giovani, strani», a cui si oppone un fermo «no»,
e poi
«un mondo, navicelle | in orbita nel cosmo in espansione»:
infine, «è sempre più chiaro | e oscuro il desiderio della vita».
Anche qui è importante notare l’accostamento lessicale, tra chiaro e oscuro: ci aspetteremmo infatti la co-occorrenza di chiaro e scuro, coppia fissa che infatti è presente in numerosissimi casi nella nostra letteratura.
Oscuro, invece, ha uno spettro semantico più ampio di scuro, e include tra i tanti anche i significati di ‘difficile da capire, da spiegare o da interpretare: un libro oscuro, concetti oscuri, una metafora oscura’, ‘che non si comprende appieno, che si conosce poco e quindi può generare inquietudine e apprensione; misterioso: un aspetto oscuro del suo carattere’, ‘incerto e sfavorevole’.
Il contrasto è quindi sì tra il chiaro e l’oscuro intesi come luminosità e oscurità (sembra infatti quasi che il poeta vada ad ombreggiare il desiderio della vita, dipingendolo con tinte fosche e luminose, rappresentando verbalmente l’effetto di luce e ombra che rende il rilievo plastico delle cose, delle masse e dei volumi mediante la graduazione dei chiari e degli scuri e il gioco dell’incidenza dei riflessi) ma anche tra chiaro e oscuro nel senso già dantesco dei termini: nella Commedia infatti chiaro assume vari significati, che vanno da quello di ‘che emana o possiede una luce, luminoso’ fino a quello di ‘ privo di incertezze o facile a intendersi, non equivocabile’, e infine il significato più alto, figurato, che indica nel Paradiso, con rif. agli occhi come strumento di percezione intellettuale:] non offuscato (da errori o pregiudizi) (fig.).
e ho visto in questa poesia proprio la stratificazione di questi significati, a indicare la duplice natura di questo desiderio di vita, di cui già Michela ci ha parlato.
- Questo stesso contrasto tra concreto e astratto, tra registro informale e quotidiano e registro alto, aulico, si ritrova anche nelle due sezioni successive: nell’immagine, potentissima e indimenticabile, dell’«aquilone rotto della croce», che associa un gioco per l’infanzia, per di più inevitabilmente rotto, alla croce dove morì Gesù Cristo.
- E poi, nella terza sezione, il contrasto tra alto e basso, sacro e quotidiano, è ancora più netto:
Qui il picco della concretezza, del “contaminarsi con tutte le forme della vita” è rappresentato dal marchionimo (cioè una parola nome con cui è noto in commercio un determinato prodotto o il nome dell'azienda che lo produce) Adidas, che inserita nel fluire della poesia sembra diventare a sua volta una parola poetica, fatta di suoni che danno il ritmo ai versi della prima strofa [rileggi], insieme alle assonanze e consonanze e alla rima interna petto: ragazzetto
«Ti guarda come una cosa
insolita, si chiude la giacchetta Adidas
sul petto, vede la madre, l'amico
ragazzetto, pensa: uno ecco
dev'esser stato
buono»
+ Immagine delle rose, che troveremo spesso nelle poesie di Rondoni.
2. Oceano, cucina
a) Passiamo ora a Oceano, cucina, le cui sezioni legate l’un l’altra dal ripetersi dell’incipit «Verrebbe da dire». Verrebbe da dire, prima, “me la sono cavata”. Verrebbe da dire, poi “me la cavo” e “me la posso cavare”, infine, a chiudere il cerchio, verrebbe da dire, ancora una volta, “me la sono cavata”.
Dove ci troviamo? Al tavolo della cucina col poeta, fermo mentre tutti dormono,
e l’argento della pioggia finisce nel buio:
l’argento è il colore della pioggia, che possiamo vedere, con gli occhi del poeta, scintillare in modo subitaneo e continuo e poi sparire, via via, nel buio nero della notte.
Ma la bellezza del verso risiede anche nel suono, nel riproporsi del suono delle consonanti: abbiamo l’affricata ʤ, prima scempia di argento, poi intensa di pioggia, che sembra riproporre il suono puntuale delle gocce che cadono, quasi un forte ticchettare, e la fricativa ʃ, di finisce, che dà l’idea invece dello sciabordio continuo della pioggia che cade, finendo, appunto, nel buio. Un verso che racchiude l’intensità e al contempo la continuità del suono.
«Verrebbe da dire: me la cavo con l’affitto e sorrido ai miei debiti, ma | cos’è ancora questo vino luminoso | e violasangue che mi esce tra i denti»
ma cos’è ancora questo vino luminoso e violasangue che mi esce tra i denti
La prima cosa che si nota è il fatto che si tratta di un’interrogativa ma che in realtà si risolve in un pensiero, in parte di una riflessione senza filtri e senza controllo, che fuoriesce dalla mente, dalla penna e dalla bocca del poeta esattamente come questo vino, luminoso e violasangue.
L’accostamento del sostantivo vino con l’aggettivo luminoso è straordinario, privo di attestazioni precedenti, così come totalmente nuova – un vero e proprio neologismo – è la parola violasangue, creata con l’accostamento di viola ‘colore fra il turchino e il rosso, con varie sfumature’ e del sostantivo sangue: un vino viola come il sangue, immaginiamo un vino rosso particolarmente carico, di quelli che lasciano l’alone violaceo sulla tovaglia, sulla bocca di chi beve. Rosso-sangue esiste in letteratura, violasangue no, è una prima attestazione. La potenza di questo neologismo è accentuata dal fatto che si spezza la frase per metterla in posizione di inizio verso.
non si dissolvono i fantasmi d’amore seduti, la luce sale, li sbianca, sono il viso di donne, le mani di stracci, carta pesta e amici che si voltano nell’acqua degli anni.
Ripetersi della sibilante à immagine della dissolvenza
Il mio amore non sta ancora fermo, mi alzo ed esco in terrazza, il cuore è un puma sulle alture, ho gli occhi di mio figlio, stanotte è la prima notte del mondo.
La metafora del puma sulle alture, che verrebbe naturale accostare all’uomo che cammina agitato e invece è riferita a cuore, dà l’immagine dell’irrequietezza, del muoversi costante e vigile avanti e indietro, in quella che è “la prima notte del mondo”.
b) La seconda poesia di questo gruppo è introdotta dal dubbio “Verrebbe da dire: me la posso cavare”.
Ancora una volta la realtà irrompe fortissima sulla scena, una scena di vita che non fatichiamo a immaginare nitidamente, questa volta grazie a un vero e proprio toponimo (nome proprio di luogo) che è anche un forestierismo (cioè una parola di origine non italiana), Stone Island.
Dove ci troviamo, dunque? In un mattino splendido, ghiacciato (e già ci sembra di vederlo, del colore tenue e freddo di un azzurro-grigio) sul molo di Stone Island, in un momento di arresto:
nel mezzo della corsa (e non del corso, come ci si sarebbe aspettati, è un corso veloce, precipitoso, una corsa, appunto) dell’esistenza – vedete come la poesia passa anche dalla scelta di una singola parola al posto di un’altra più prevedibile –
- e sentii | tutta l’oscurità del mare, | l’enigma, il suo respirare | che arriva in questa cucina, in una città | italiana, nel silenzio spogliato, | ed è il vibrare del frigorifero | a trovare la stessa nota dell’oceano, | la luce del video | acceso a nessuno | rende a queste stanze un chiarore di fondale.
«e sentii»: un nuovo verso, isolato, prima e dopo, introdotto dal trattino, che ci fa sentire proprio l’arresto tipico di uno di quei momenti della vita in cui si avverte, si realizza, qualcosa.
E cosa sente? Sente l’oscurità del mare, il suo respirare che arriva nel silenzio spogliato: ancora una volta il ritorno insistito della sibilante, che ci dà il suono del mare, del respiro e anticipa il vibrare del frigorifero, che trova la stessa nota dell’oceano: à ecco un esempio chiarissimo di quella commistione tra sublime e quotidiano, tra trascendente e concreto, che caratterizza la poesia di Rondoni; à quel mischiarsi di parole e di immagini, capace di trasformare una stanza, col chiarore della tv (o del computer, non è specificato) e la vibrazione del frigorifero, in un fondale marino, oceanico, chiaro.
Prima il mare era oscuro, ora il fondale è chiaro: torna nuovamente il contrasto chiaro / oscuro della prima poesia, con tutte le conseguenze sul piano semantico che abbiamo visto. L’oscurità del mare è un enigma, non si può penetrare; il chiarore di fondale permette, invece, di vedere.
3. So e non so il punto centrale della rosa, della cosa
Una poesia che dice qualcosa e il suo esatto contrario.
Inizia con So e non so e prosegue poi con l’anafora di “so” che si snoda per tutte le strofe successive:
so e non so,
ancora so e non so,
rasoviso, sorriso, so vivere
Ma anche la stessa sillaba è ripetuta al contrario di sé stessa: rosa, cosa, mimosa, misteriosa, cosa, fulminosa.
So e os che si ripetono a creare una trama fonica, lessicale e semantica.
In questa trama ho ravvisato un quadro, non solo per le immagini nitide come «gli archi d’acqua che innaffiano i campi», che ci pare di vedere congiungere un tratto di terreno a un altro, magari creando il gioioso effetto arcobaleno che si vede a volte nelle giornate di sole, ma anche perché i colori sono stesi dal pittore a RASOVISO. Vedete l’insistenza sulla sillaba SO? Ma soprattutto rasoviso è un interessantissimo neologismo, creato sul modello di rasoterra, che immagino significhi ‘rasente il viso’, quindi all’altezza del volto.
Gli ultimi versi trasformano il so in se: «so vivere di tutto | e di niente se resti qui, o se nella fuga dei portici ti volti a salutarmi».
Anche questa fuga dei portici ha un duplice significato: innanzitutto, si tratta di un tecnicismo dell’architettura, il cui il significato proprio è quello di ‘successione di ambienti o elementi architettonici in prospettiva: una fuga di colonne, di archi’, ma naturalmente porta con sé anche l’idea del ‘fuggire’ (l’immagine della persona che, andando via, si volta a salutarlo).
Questa poesia ci offre un chiaro esempio di quella che è una delle immagini (e delle parole) che maggiormente caratterizzano la poesia di Rondoni: la rosa.
4. Rosa notturna che ho esplosa in testa
«Rosa notturna che ho esplosa in testa» (sentite la potenza di quest’immagine): questa esplosione è seguita dalla ferita, dalla rovinosa festa, le inferriate tremano e c’è, infine la deflagrazione. Vocaboli afferenti al campo semantico della guerra, della distruzione, accanto – per contrasto – alla delicatezza della rosa (due volte nel testo) e delle aeree fioriture.
- Questa poesia è un flusso ininterrotto, non contiene alcun segno di punteggiatura, nemmeno i trattini, spesso presenti nei testi di Rondoni. Inizia con la rosa e finisce con le cose senza permettere di prendere fiato, precipita al punto finale come i detriti leggeri di un’esplosione cadono a terra cullati dall’aria ancora in movimento.
L’assenza della punteggiatura fa sì che ci sia anche la sostantivizzazione di un’espressione: «tremano le inferriate la cassetta di bottiglie i baci i mai più» in un climax ascendente che va dal concreto all’astratto, culminando proprio in questi “mai più”, tutti i momenti che non ci saranno più, o tutte le volte che “mai più” è stato detto, come una promessa.
Come Rosa notturna che ho esplosa in testa, che funge da raccordo tra il secondo e il terzo gruppo di poesie, anche queste due sono tratte da La natura del bastardo: come abbiamo visto, questa raccolta ci racconta la fame insaziabile del poeta, il suo mescolarsi con tutte le forme della vita e al contempo quello che è l’unico motore del viaggio, l’unica cosa che conta e che possiamo fare: amare. E allora troviamo il lessico della vita, dai vagoni all’erba alta della collina; troviamo di frequente la parola fame, che è proprio quella fame insaziabile, mai soddisfatta; troviamo ancora onde, mare, esplosioni, il contrasto, ancora, tra oscurità e luminosità.
5. E tu mi aspettavi nel diluvio, occhionda
E tu mi aspettavi nel diluvio
occhionda, nuvole e mari
che escono dai vagoni,
tienimi le mani
fermami la bocca che trema
in qualsiasi cosa tocchi
per la fame nell'alba gelata
– e per riaprirli nella vita incendiata
chiudimi gli occhi, chiudimi gli occhi
Ciò che colpisce subito della prima delle due poesie è sicuramente il neologismo occhionda: occhi-onda, occhi che sono come un’onda.
Il contrasto è qui tra l’alba gelata e la vita incendiata: è l’amore che incendia la vita, è l’amore che dà forma a questa dismisura che forma non trova, finché la persona amata non arriva con i suoi occhi-onda, a tenergli le mani, a fermare la bocca che addirittura trema per l’insaziabile fame, in qualsiasi cosa tocchi.
6. Ma ora che siamo io e tu
La seconda invece è una perfetta manifestazione del contrasto lacerante e vivissimo tra il quotidiano e il divino, tra il concreto e il sublime.
AMARE: Le strofe sono legate dal verbo amare (ecco che ritorna l’amore, unico motore dell’esistenza, ciò che – solo – possiamo fare): «amali come non so fare io», «amali, più di me se sei | dio», «amali se sei dio», «amali più di me», «amali più di me, ti prego», e, tra parentesi, quasi sussurrato e posto in dubbio dall’avverbio forse, ma al contempo in posizione di inizio verso, quindi in evidenza, «amare è | guardare qualcuno che taglia i campi e | sconfina».
IO: Si gioca molto con io, che è contenuto in dio e in varie altre parole (io, dio, se sei dio, se sei dio, nell’oblio insieme con l’io, mio), come se fosse proprio l’io, integro, a trasporsi di parola in parola, a divenire di volta in volta dio e a cadere nell’oblio, senza perdere mai coscienza di sé stesso.
IO E TU: L’io è anche separato fortemente dal tu del secondo verso, non solo perché tra io e tu si va a capo («Ma ora che siamo io | e tu | nella navata che mi zooma…» e tu è anche isolato nel verso), ma anche perché sorprende l’accostamento con “tu”, laddove generalmente quando si prepone il pronome personale soggetto io segue te, e non tu (io e te). > forma viva al Sud ma sempre meno attestata e probabilmente destinata a scomparire
ZOOMARE: Molto forte il forestierismo zooma dal verbo zoomare, scritto proprio con due o: si tratta di una forma ibrida, parzialmente adattata (altrove adattata come zumare, e così messa a lemma nei vocabolari): un verbo che a primo acchito contrasta con l’ambientazione nella navata di una chiesa, in cui ci si aspetterebbe un lessico diverso.
ALTRO: Qui gli occhi dell’amata non sono più onda, ma sono occhi foresta, e aprono la strada a parole e immagini come erba, collina, campi, agli uccelli impazziti a cui sono paragonati i nomi nel vento.
Un’immagine particolarmente importante in questa poesia è rappresentata dalla spina e dagli spini: la «spina di luce» che «incide per sempre il buio feroce» (ecco il contrasto chiarore/oscurità) e richiama «nella tua testa | incoronata di tempesta» (immagine potenziata dalla posizione di rima) la corona di spine di Gesù, e «la sfida alla tua tempia divina | di spini infiniti», accostando ancora divino e umano, alto e basso.
Un contrasto evidente fino all’ultimo verso dove convivono, tra l’altro con una persistente allitterazione, «diamanti e detriti».
«Qualcuno ha scritto: in principio era la danza. Perché il Verbo – che è in principio – deve aver avuto un certo ritmo per creare, per mettere in moto la danza degli elementi. I loro misteriosi incontri. La danza stupita da cui è nata vita. Perché la vita danza» (da Noi siamo quelli della danza).
7. La piccola arpa delle costole
RIMA INTERNA E CHIASMO: Questa poesia è ritmo, è musica da ascoltare, da danzare:
lo si nota subito dalla rima interna «sentita con le dita», dal chiasmo che coinvolge l’ordine dei costituenti della frase nei primi versi: prima S-V, poi V-S:
«la piccola arpa delle costole […] cerca forma in te,
si oppone a ogni | incuria l’esistenza»
ARPA: L’arpa delle costole, piccola arpa, è sentita con le dita, e immaginiamo subito di sfiorare con le dita il busto di una donna, di una ballerina, magra, flessuosa, e di accompagnare il suono della musica (forse, crearlo) passando le dita su questi fili che risuonano.
La musica è un’entità sovrana a cui lei dà corpo, come un tramite che consente al divino di manifestarsi.
ANNIDARSI: Nella sua danza si annidano i pianti che non lasciamo uscire: annidarsi è un verbo di uso comune che ha tre principali significati:
- Porre nel nido o come in un nido; anche in senso figurato ‘accogliere’
- Più comune il riflessivo annidarsi, fare il nido in un posto, detto specialmente di insetti, topi e altri animali. Per estensione ‘collocarsi, piantarsi in un luogo’: detto ad esempio dei nemici, o, come si legge in Dante, ‘trovare posto, essere contenuto’: «onde nel cerchio secondo s'annida / ipocresia, lusinghe e chi affattura, / falsità, ladroneccio e simonia, / ruffian, baratti e simile lordura» (Inf. XI. 58).
I pianti che nella danza si annidano sono acquattati, un po’ come il nemico pronto a saltare fuori ed attaccare al momento giusto (come il pianto, che sgorga quando meno ce lo aspettiamo, e spesso nelle occasioni meno consone) ma anche accolti, protetti e al riparo come gli uccellini annidati nel rifugio creato loro dalla mamma.
Ancora musicale, cantilenante, è la chiusura della poesia: «senza danza, senza danza nulla è vero…».
E allora proseguiamo, in conclusione, con l’ultima splendida poesia che Davide ci ha letto.
8. Dove il rosso trema di te
Qui tornano i toponimi (i nomi dei luoghi) che ci collocano con precisione a Roma, tra il Gianicolo e il lungotevere Testaccio.
«Dove il rosso trema di te
dove il corpo trema buio re
dove la luna di Roma stanotte
precipita nel no»
Anche qui un ritmico precipitare, una musica per una danza che non c’è: il rosso trema di te, il corpo trema buio re: con l’immagine di un colore che trema, l’anafora di trema, la rima di te : buio re che sembra richiamare un’antica filastrocca immaginata, e che poi precipita, col verbo precipitare ma anche con la struttura della strofa, «nel no»: un no perentorio, senza soluzione, in fine di verso, che assume le sembianze di un luogo.
«Io avrei bisogno che tu danzassi | e danza non c’è»: l’assenza di articolo conferisce al sostantivo danza una personificazione, è ancora una volta un’entità superiore che si impadronisce di tutto e si manifesta dove decide lei.
«c’è solo fogliame di pianto, fogliame
di pianto e
nel vento
c’è una grande meravigliosa città
non parla non muove le sue vie le sue magie»
Ancora una ripetizione prima di rallentare: «c’è solo fogliame di pianto | fogliame di pianto» e «nel vento» (questa rima imperfetta rallenta il ritmo) «c’è una grande meravigliosa città | non parla non muove le sue vie le sue magie», un ripetersi della nasale bilabiale, la <m>, a potenziare la magia.
CONTRASTO PRIMA PARTE (INTERIORE) E SECONDA (QUELLO CHE INVECE C’È)
- Questa prima parte è priva di punteggiatura, poi, quando si descrive che cosa, invece, c’è, la punteggiatura torna, tornano virgole, trattini, punti: è il contrasto tra quello che è interiore (il pensiero, il ricordo, l’immagine, il desiderio) e ciò che invece è realtà.
RICAPITOLARE: Infine, il passo, la curva della schiena, ricapitola il mondo: ricapitolare è ‘riepilogare per scritto, a voce o anche mentalmente, in modo succinto e per sommi capi, quanto si è già esposto, trattato o pensato; riassumere nei punti salienti’ ma anche ‘capitolare nuovamente’ ‘arrendersi al nemico sotto determinate condizioni; pattuire la resa, cedere’: e allora, «reinizia la scena».