Poesia e musica
Articoli e poesie sulla canzone. Poesia e musica intrecciate nelle parole. Interviste con artisti e cantautori.
Poesie
A Lucio Dalla, in mortem, ah cazzo
da Rispondimi, bellezza, Pellegrini editore, 2023
Piccolo come un figlio adottato da tutti
strano come un consiglio, un accordo
che non t’aspetti
avevi un milione di parole da suonare
ma chi sa quanto silenzio
hai dovuto traversare –
e ora che tu e Dio vi guardate sbigottiti
il primo a rompere il ghiaccio sarà lui.
Allo sguardo da cocker e angelo che farai
dirà “qui c’è una nuova differenza
tra musica e silenzio, sai.
E ora fammi una tirata delle tue non-parole,
ogni mattina le voglio canticchiare
faremo coppia, comincia tu
chiameremo fuori là il sole, lo vedi?
sul mare”.
Canzone napoletana
Sei arrivata in macchina con Pino
non immaginavo che fossi il mio destino
la città era sognante, caotica e regale
il treno mi lasciò lì con il mio bene il mio male
si pensa sempre di aver qualcosa da fare
mentre invece la vita è fatta per trovare
mio destino, mio dolce mastino
mio destino, mio dolce mastino
Non ho segreti, non ho giustificazioni per te
l’amore un movimento più grande dei perché
cosa nasce dalle nostre risate e dai silenzi improvvisi
il golfo è nostalgia dei tuoi sorrisi
mio destino, mio dolce mastino
arrivavi in macchina quel giorno con Pino
E la città cantò che sa solo cantare
la città suonò che sa solo suonare
per la vita poi ci si può arrangiare
qui dove importa solo ridere e amare
Mio destino, mio dolce mastino
afferra, non mollarmi il cuore
mordi più a fondo se devo affondare
nelle onde e nella luce pazza del mare
la vita è la nave, le vele sempre più grandi
da seguire e imparare a navigare…
Mio destino, mio dolce mastino
non andartene via in macchina con Pino
accetta il mio bacio sperduto, il mio inchino
vieni come fa Dio, infinito e vicino…
I video
Eventi e articoli
- Conta su di me. Canzoni e poesie con Cristiano Godano a Ercolano
- “Tu ca nun chiagne” la canzone italiana più bella. Conversazione con Davide Rondoni – L’Isola
- Il corpo del musicista. Concerto con Danilo Rossi – Il Piacenza
- Lucio Dalla/ 1. Un uomo “curioso” del mistero della vita – Il sussidiario
- Musica: Neri Marcorè a Jesi per omaggio Raffaello Sanzio – Ansa
- Il tour. BandaDante e Ambrogio Sparagna in viaggio con Davide Rondoni – Avvenire
- Roberta Giallo, esce “Canzoni da museo” – Bravonline
- Con Cristian Carrara, Rapimenti d’amore, teatro Coccia Novara
- Con Cristian Carrara su san Paolo, Destinazione del sangue
- Destinazione del sangue – Meeting
- Velocità fossile con Pierluigi Virelli
Sulla canzone romagnola, liscio e cante, e certi modi di dire
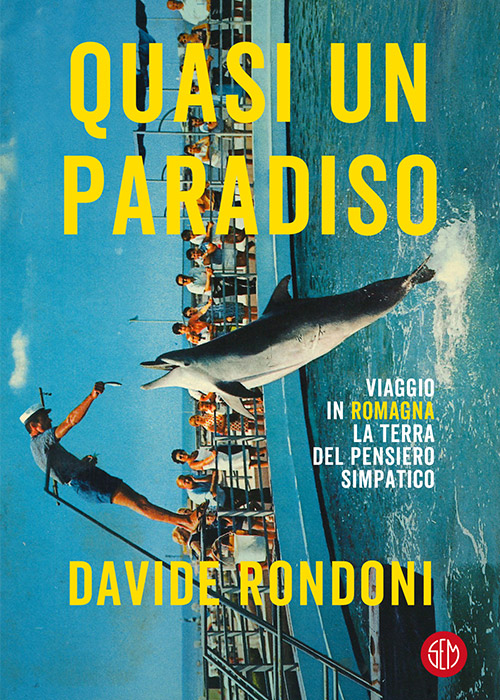
XIII
“Canta che non ti passa mica, e quindi devi cantare sempre”
Secondo Casadei
Il liscio romagnolo è una invenzione pura. Nel senso che le sue radici non sono veramente nella musica o canzone popolare romagnole. Le cante romagnole, i canti dei contadini, dei braccianti, dei lavoratori e delle donne, non banno nulla di quel che oggi conosciamo come l’armamentario allegro, luccicoso e pop del liscio. L’inventore del liscio romagnolo avrebbe dovuto fare il sarto, ma era innamorato del violino, ed è stato un geniale divulgatore della musica dei ricchi (il valzer) nelle aie, nei circoli, nelle piazze, nelle balere dei semplici e dei poveri. Secondo Casadei, denominato lo strauss di Romagna, ha composto più di mille canzoni. Partito con una orchestrina di sei persone ma già innovatore con l’inserimento di sax e batteria su un organico composto da chitarra, due violini, basso e clarinetto, si ritrovò in vent’anni, unendosi poi al nipote Raoul suo continuatore, in un orchestrone che suonava tutti i giorni dell’anno eccetto il 2 novembre, il primo giorno di Quaresima e la vigilia di Pasqua.
“Romagna mia” il suo successo più noto nel mondo (cantato in vari modi da Gloria Gaynor, Jovanotti e Goran Bregovich, ma canticchiato pure da Giovanni Paolo II) nacque quasi casualmente. Durante una delle registrazioni a Milano presso la Voce del padrone (un certo successo era già arrivato) un sassofonista aveva la raucedine e andava sostituito un pezzo. In borsa Casadei aveva un valzerino che teneva per ogni evenienza e che aveva titolato “Casetta mia”. Il direttore artistico della casa discografica, l’occhiuto Dino Olivieri, autore anch’egli di canzoni memorabili, suggerì di intitolarla “Romagna mia”. Casadei accettò e dopo qualche settimana dall’uscita del disco si accorse che un facchino in stazione ne canticchiava il motivo. Quello era il suo scopo, un po’ di oro in gola ai semplici. Quello per lui il test. Così come diceva ai suoi musicisti – a volte veri mostri che smessi i lustrini delle pailettes dell’orchestra Casadei come di altre mitiche orchestre di liscio la sera con nomi americanizzati incantavano nei jazz club o nei locali più colti- che il liscio non sarebbe mai finito finché ci sarà una persona che ha voglia di ballare. E infatti, dopo l’esplosione che il suo continuatore Raoul, vero leone del liscio, e ora che pronipoti e seguaci di nuova e nuovissima generazione continuano a interpretarne le canzoni e lo spirito, rinnovando e mescidando forme e generi, il liscio in Romagna sta conoscendo nuove fortune, grazie anche all’animo di fiutatori dei gusti musicali d’avanguardia e dei curiosi rivolgimenti delle mode come Sangiorgi, patron del festival della musica indipendente che ha inventato “La notte del liscio” con grande successo e la partecipazione di centinaia di migliaia di persone.
Il liscio è musica da ballo, e da compagnia. Le cante romagnole, struggenti e bellissime, sono spesso canti di lavoro, elegie, inni d’amore solitari. Esprimono il lato malinconico e duro dell’animo romagnolo, quello in un certo senso più vero, il tellurico, il magmatico da cui sa erompere anche la allegria, mai leggiadra o stupidotta, del liscio e delle sue canzoni dal testo a volte surreale e inventivo. “Tu sei la mia simpatia”, “Ciao, ciao mare”, etc sono motivetti di poche note (come ogni vero musicista sa che dev’essere una vera canzone) che esaltano la Romagna estiva, dei corteggiamenti allegri e da cartolina. Con punte di suprema ironica saggezza. Come ad esempio in quello che ritengo essere un manifesto per le ragazze romagnole. Sono le parole tratte da “Simpatia”
Tu sei la mia
simpatia
simpatia
simpatia…ah ah
il tuo sorriso
è una canzone
su quel musetto
acqua e sapone.
Io ti darei
tutto quello che vuoi
ma tu non chiedi mai
tu solo dai!
E sei la mia
simpatia
simpatia…ah ah
simpatia.
E sei felice
anche con poco
una carezza
e un po’ di fuoco…
e t’accontenti
d’una bugia
simpatia
simpatia.
Un vertice assoluto…. “Io ti darei/ tutto quello che vuoi/ ma tu non chiedi mai/ tu solo dai”. Le ragazze sorridono, capiscono, non sono acide femministe, sono femmine e sanno che sotto non le metti.
Questa gratuità della gioia, della offerta, dell’allegria, è un vertice del senso romagnolo del vivere nel suo aspetto lucente e appassionato.
Così come all’opposto – un opposto che sempre si tiene al suo contrario- in testi come La majé, la maggiolata, scritta da Aldo Spallicci e musicata dal geniale compositore Cesare Martuzzi a inizio ‘900 come rifacimento dello stile delle più antiche cante, abbiamo invece la assolata e stordita campagna, il gallo che canta e che alza la cresta (allusione freudiana?) e i rami di fiori sulla finestra sia come ornamento che come deterrente per le formiche. Un mondo contadino, immerso nelle durezze e nei ritmi lenti della terra, attento, come nel capolavoro “Bèla burdèla” alle finezze sensuali di una bellezza mai sofisticata e mai banale.
I “canterini romagnoli” coro nato dal sodalizio Spallicci – Martuzzi era composto da gente che non sapeva leggere la musica e allora Martuzzi inventò un modo per loro, per insegnargliela. Perché il romagnolo vero canta, comunque.
Come scrive in una bellissima e breve poesia di Walter Galli, poeta di Cesena.
Lo e chènta
Ala vetta duna piòpa / o tra aglj ombri d’un macion/ echènta dala matèna ala sera /chlè un piaser a santil. //Me a vreb dmandéi duchu sla chèva fóra / totta cla vója ad cantè /che t sint chu i dà cun un góst/ una fórza un’alegria,/ che pè chu jépa da s-ciupè e cór:/ e un nè che un uslin./ Un cuslin da gnint/ cun la vita lighida a un fil / chebasta un spanèl dneiva/ la sfrómbala d un burdèl/ un gat chu i sèlta adoss / e lè zà mórt: un pogn d penni e basta. /A lsal? a nesal? Lo e chènta.
Lui canta. Sulla cima di un pioppo
o tra le ombre di una macchia
canta dalla mattina alla sera
che è un piacere sentirlo.
Io vorrei chiedergli da dove se la tira fuori
tutta quella voglia di cantare
che senti ci mette un gusto
una forza un’allegria,
che sembra gli debba scoppiare il cuore:
e non è che un uccellino.
Un cosino da niente
con la vita legata a un filo
che basta una spanna di neve
la fionda di un ragazzo
un gatto che gli salta addosso
ed è già morto: un pugno di penne e basta.
Lo sa? Non lo sa? Lui canta.
Ma da dove viene questa allegria che romagnoli portano sempre nel mondo, anche nei più cupi momenti o quando le ombre della fatica s’addensano? Quella attitudine per cui anche ai funerali c’è quello che la patacata la dice e fa sorridere, o che sdrammatizza anche in situazioni di rischio come sintetizza il detto origine ravennate:
a s‘avem d’anghèr ma us divertèsum – abbiamo avuto da annegarci ma ci siamo divertiti
Eh, da dove viene?
Da dove viene questo estremo senso della allegria, quasi strappata coi denti alla notte, un’allegria barbara e a volte feroce e pur capace di dolcezze mai svenevoli?
Credo che venga pur con mille imbastardimenti direttamente dalla natura latina, romana. Un segno ereditario che viene direttamente da Cicerone o Catone o Virgilio o Orazio… Insomma dal midollo verbale della latinità. Si tratta, infatti, quasi sempre di un’allegria verbale, legata alla sapidità dei motti, alle battute, alla capacità poetica del linguaggio.
Parole come Patàca, sburon, su cui abbiam già detto o altre espressioni come invell, da nessuna parte, malèta sacca maschile dei maroni, invurnid, invornito, rincoglionito, quaioni, smataflòn etc. sono alla base della allegria dei romagnoli, che appunto è una allegria di tipo “espressivo” ovvero retorico, nutrito da antiche linfe di retorica e oratoria latina poi arricchita dai colori di tutte le lingue. Un romagnolo soprattutto fa ridere per come parla, per quel che dice.
C’è una capacità del narrare colorito che sicuramente viene dalle antiche veglie (così come avviene per l’abitudine del “Trebbo poetico” antenato verace dei festival di poesia e dei patetici poetry slam odierni).
Come dice questo efficace quadro tratto da una canta dei Canterini Romagnoli.
E’ e cunté e’ rapeva pr e’camèn/ do che sbruntleva in gran sgumbéj la bura/ ch’la purteva a la nota e al stël là fura/ al parôl banadeti d’avless ben (E il raccontare saliva per la coppa del camino/ dove sbrontolava in gran scompiglio la tramontana/ che portava alla notte e alle stelle là fuori/ le parole del volersi bene)
Non è un caso che tutti i nostri maggiori scrittori, da Dante a Leopardi, a Manzoni abbiamo dovuto mentre scrivevano affrontare una “questione della lingua” italiana, facendo grande attenzione al rapporto coi dialetti e con le vive mutazioni.
Il giornalista e scrittore Paolo Gambi sul suo sito ha lanciato una specie di “contest” cioè un gioco chiedendo ai romagnoli le parole che il mondo ci invidia, ed è un susseguirsi spumeggiante di invenzioni linguistiche, così come lo sono i nostri proverbi.
In questo, come aveva visto un grande poeta russo, Osip Mandel’stam, sta una natura tipica delle lingue che si sintetizzano e al tempo stesso si nascondono nell’italiano: l’esser pronunciate con movimenti della lingua che batte sui denti, e poi con le labbra, insomma con una natura affettiva e teatrale, una lingua tutta volta all’infuori, come un bacio, un saluto. Una lingua degli affetti, che non a caso trova nel canto e nella poesia la sua massima espressione. E nella oratoria, specie comica, come dimostra il fatto che tutti gli importanti comici italiani sono “dialettali” o venati di dialettismi. Nel romagnolo si esalta questa qualità generale dell’italiano sorto dalla grande latinità, nel suo “involgarirsi” e nell’incontro con espressioni e influenze che vanno dall’arabo al germanico. E l’allegria appunto è innanzitutto una allegria espressiva, linguistica.
Adamo, che sicuramente era romagnolo, aveva dato un sacco di nomi divertenti alle cose nel paradiso terrestre.
Alla talpa che era un po’ cieca diceva “Tan vì un prit in tla nèiva: Non vedi un prete in mezzo alla neve”
Oppure, quando vedeva che non gli riusciva di tenere ferma una gallina per dargli, appunto, il nome gallina diceva: “L’è com lighì e chèn cun la zunzezza: È come legare il cane non la salsiccia”. E quando si metteva a tavola nel Paradiso terrestre, sentenziava, da solo, beato: L’è mei avèi e coul sèn sotta i calzoun rot che i calzoun sèn soura e coul rot: È meglio avere il culo sano sotto i calzoni rotti che i calzoni sani sopra il culo rotto. “E poi, soddisfatto: “La pida cun e parsot la pis un po’ m’a tot: La piadina col prosciutto piace un po’ a tutti.
Poi quando Eva, nonostante Adamo le continuasse a dire “T’e da scorr quant al pessa al galèni“: Devi parlare quando pisciano le galline (Un modo per dire di stare zitti), lei gli ha fatto una gran maletta (termine di ascendenza spagnola che da valigia diviene sacca dei maroni), tanto che gli strisciava per terra, con la storia della mela e del serpente, e dai su sta mela, dai su sto serpente, lui che era uno sborone, ha fatto la patacata…
E anche trovandosi in terra, in questa “valle di lacrime” come sapevano mia nonna e Leopardi, non ha perso però il suo modo colorito di dire le cose. E ha chiamato le cose con il loro nome, compreso le malattie, ma a suo modo… L’è scorg cme e caval ad Scaia e dla bocca u’s ved e bus de coul: È piagato come il cavallo di Scaia e dalla bocca gli si vede il buco del culo (Detto di persona gravemente malata e magra).
E alla moglie che ancora gli sfrantumava i maroni dicendo che era colpa sua di lui se non eran più in Paradiso, Adamo, addentando una giuggiola, faceva solo: Un s’fa un fòss senza do rivi: Non si fa un fosso senza due rive. Come dire che in certe cose la colpa non è mai da una parte sola.
Poi stendeva le gambe sotto il tavolo e cantava “La vita tocca del Paradiso il confine/ quando vedo le piadine, il mare, le colline…”
Altri scritti
A Sanremo cantano. Ma gli italiani cantano? Si chiama festival della canzone italiana. Perché noi italiani sappiamo cantare. C’è lo riconoscono in tutto il mondo. Anche se ti trovi in un ristorante in capo al mondo e dici che sei italiano, salta fuori qualcuno con l’armonica o la chitarra e intona un “o’ sole mio” o “lasciatemi cantare”. Insomma, ci prendono per gente che ama cantare. E infatti a Sanremo cantano. E grazie anche al bravo Carlo Conti, molti stanno incollati al televisore a vedere che si canta. Ma la questione che in questi giorni mi fa tremare è: gli italiani cantano? Intendo, mentre lavorano, mentre vanno in auto, mentre sono coi figli o con gli amici, cantano? O fanno come i cinesi, che cantano solo nei karaoke…La questione è seria. Credo che occorra diffidare di un uomo o una donna che non cantino. Significa che non hanno il cuore pieno o il cuore ferito. Perché si canta per una gioia che straripa o per un dolore che fa uscire melodia. Solo cuori medi, tiepidi non cantano mai. Ma già se lo chiedeva Pasolini: come mai non si sente cantare più nelle nostre strade? È vero che oggi molti mestieri non permettono di cantare. Nei campi veniva più normale cantare di quanto, ovviamente, possa venire oggi a un commercialista in ufficio o a un consulente aziendale in mezzo ai clienti. Uno tempo, senza televisore a cui guardare Sanremo veniva più facile in cerchio nell’aia condividere canzoni e racconti. Ma il punto non è solo nelle condizioni di lavoro o di convivenza. Certe voci che anche a Sanremo hanno spopolato ( da Modugno a Villa ad Albano) erano voci di certo con tratti quasi popolareschi, di certo televisivamente imperfetti. Avevano il tono e la sfrontatezza di certe canzoni improvvisate in cucina o per le scale. Avevano quella grana di canzone condivisa che oggi è di molto diradata. Sembra che la musica dal vivo per strada (eccetto nei momenti organizzati ad hoc) la si possa sentire solo grazie a qualche slavo che suona nelle metropolitane o agli incroci per tirar su qualche soldo. Abbiamo di certo perso la voce. Gli italiani non cantano più? Qualcuno pensa che dipenda dal fatto che sono tristi, che sono impoveriti. Insomma, che noi italiani siamo meno agiati di poco tempo fa e dunque un po’ depressi. Certo, il depresso non canta. Ma ai tempi dei canti nelle aie o dei giovani fornai in bicicletta che fischiettavano e cantavano non giravano certo più soldi in quelle tasche. Evidentemente, si tratta di una depressione. Non si tratta di una questione economica. Anche da poveri si canta. Pensiamoci: mentre molti sono i punti di diffusione di musica continua, ronzante, a volte assordante, di infiniti video musicali passati in ogni bar, stazione, aeroporto, per il resto non si sente cantare nessuno in giro. Nessuno, o quasi. A parte gli slavi o gipsy di cui sopra, non capita quasi mai di sentire un uomo canticchiare per strada, o due amici cantare in pizzeria o altrove. Vergogna? Pudore? Eppure, capita, e se si guarda bene si nota. Intendo che ci sono punti di resistenza, o meglio di insorgenza del canto. Gruppi di giovani amici che amano trovarsi a cantare, magari di notte su un prato, tanti cori parrocchiali o di altro genere, tanti ritrovi di musica popolare con giovani che reimparano canti antichi, nei vari festival della Taranta, della zampogna e così via. Una ricerca di canto vero, fisico, non mediato dal video o dai tanti apparecchi diffusori. Sono segni contraddittori. L’Italia canta o non canta più? Si canta solo al festival? O a aguzzat l’orecchio si sente un canto italiano diffuso, segreto, magari sottotraccia?
Se non cantiamo chi siamo? Anche Leopardi titolo il suo libro “Canti”. Perché il canto è il segno della presenza dell’anima, e che tale anima ha voce. Se l’Italia incollata a Sanremo potesse riscoprire anche il gusto di cantare di più – da soli e insieme – allora davvero sarebbe un bel festival. Ma per cantare occorre un motivo che riempia il cuore. Che lo apra. Qualcosa di grande. Di più grande della ricerca del successo personale. Se non c’è non si canta. Quando non si canta più se non per farsi notare, ben allora, non è più canto ma un’altra cosa. I bizantini dicono che l’uomo ha creato un sacco di meravigliosi strumenti per suonare. E oggi con l’ausilio della elettronica che prodigi si possono fare con poco. Ma Dio ha creato la voce umana, che dunque è il più perfetto degli strumenti. Quel che introduce di più a un senso semplice del miracolo. Ad esempio, provate a cantare domani in auto coi vostri figli. Se non lo sapete già, ecco, succederà un piccolo grande miracolo.
(da Avvenire)
I maestri del pensiero Novecentesco, scettici e dubitosi, cosa pensavano che avrebbero cantato, i giovani delle suburbie, e anche i borghesucci del centro, quelli che ascoltano e canticchiano la TRAP? Successo, soldi, donne oggetto. E il mito feroce della fama. Se non c’è altro orizzonte che la storia, e la riuscita nella storia, che cosa cantare se non il successo, la fama, scimmia dell’eternità? Lo aveva scritto Eliot: usura lussuria e potere sono i nuovi dei. Finché rimaneva una cosa da dibattito filosofico, una poesia si poteva far conto di non vedere. Le élite mica leggono poesie…Ora è nelle canzoni dei ragazzini, dei digli portati a vedere i concerti in discoteca dalle mamme. E allora ci se ne accorge. Cantano il deposito del Novecento, della modernità intera. Cantano il confuso hangar di un mondo annullato nel suo valore in una lingua smangiucchiata e viva, composta anch’essa da pezzi presi da vari scaffali, sempre quelli, dell’hangar di un poliglottismo povero. Una lingua standardizzata come dev’essere quella che “funziona” sui grandi numeri, ma più viva certo (so che mi attiro antipatie) di quella cantautorale dei De André o Guccini, paraletteraria e corretta. Di cosa dovrebbero cantare dopo che gli hai tolto la speranza? Cantano ciò che luccica, sprofondati in un nero di angoscia e allegria di plastica che non loro hanno generato, ma in cui sono stati generati. E lo fanno bene, perdio, con ironia e ferocia. Lo fanno con il gioco delle parti con gli amici-rivali Indie, con stili importati pateticamente dagli Usa (come sempre fin dai tempi di Celentano che imitava i rocker), con una stella fissa negli occhi: il successo. Pur se sono nati in quartieri di buona famiglia, come Dark Polo Gang, cantano o meglio smozzicano, i sogni di benessere di “tutti”, fatti di droghe, sesso, soldi. A imitazione delle star americane, fanno banda, si contrastano con altri gruppi mediante il “dissing”, disprezzo espresso nelle canzoni, che può tracimare, come nel caso di Notorius e Tupac, in faide e morte. C’è un senso di chiuso, esplosivo, cerchi concentrici che si divorano tra loro, una logica da clan. Ma cosa avrebbero potuto fare di diverso? il Novecento ha lasciato molto altro ai ventenni di oggi, se non un sacco di retorica, di parole tanto alte quanto spesso morte nel momento in cui vengono pronunciate? C’è molta strategia e furbizia, molta cupidigia in questo fenomeno. C’è molta industria e concorrenza economica nella enfatizzazione che i media fanno di queste cose spacciandole per sottoprodotti culturali da suburbia. Ma c’è anche una lingua che si sfalda e si ricompone per cellule intorno a una muta disperazione, quasi in una tensione (avrebbe detto Ungaretti) a dire la vita. La vita come è, per questi ragazzini che vedono i leader mondiali da Trump al Papa avere profili social di milioni di persone come i loro idoli, in una parificazione e omologazione dove davvero inizia a contare sempre di più, per sentirsi se stessi, decidere di che musica sei, di che clan sei, di che slang sei. Cantano la crisi assoluta della modernità, cantano quello che inascoltati avevano predetto Eliot e Pasolini. Lo fanno con la bella sfrontatezza dei vent’anni portando alla ribalta mondi che i genitori non immaginano. Avevo scritto più di dieci anni fa su questo giornale: i ragazzini sono la bomba su cui siamo seduti. Ora si fanno sentire. Certo non sono tutti uguali, non bisogna cedere alle omologazioni utili solo al marketing. Ma non aver paura di ascoltare.
(da Quotidiano Nazionale)






