Prefazione al libro
Un doppio affascinante viaggio cattura il lettore di questo libro pieno di meraviglia e di studio. Pieno di incanti e di notizie. Il nucleo originario della poesia araba, dei poeti arabi prima dell'Islam, ovvero della porzione di arabi stanziati a nord della penisola arabica provenendo da sud, ci appare in tutta la sua sfolgorante forza. Un doppio viaggio, uno in ciò che è lontano, l'altro in ciò che è dentro di noi, Poesia della seduzione, del viaggio, dell'amore e della nostalgia. E sono già belli i nomi del genere di questi componimenti, che Goethe conosceva e che hanno animato la cultura poetica europea da secoli.
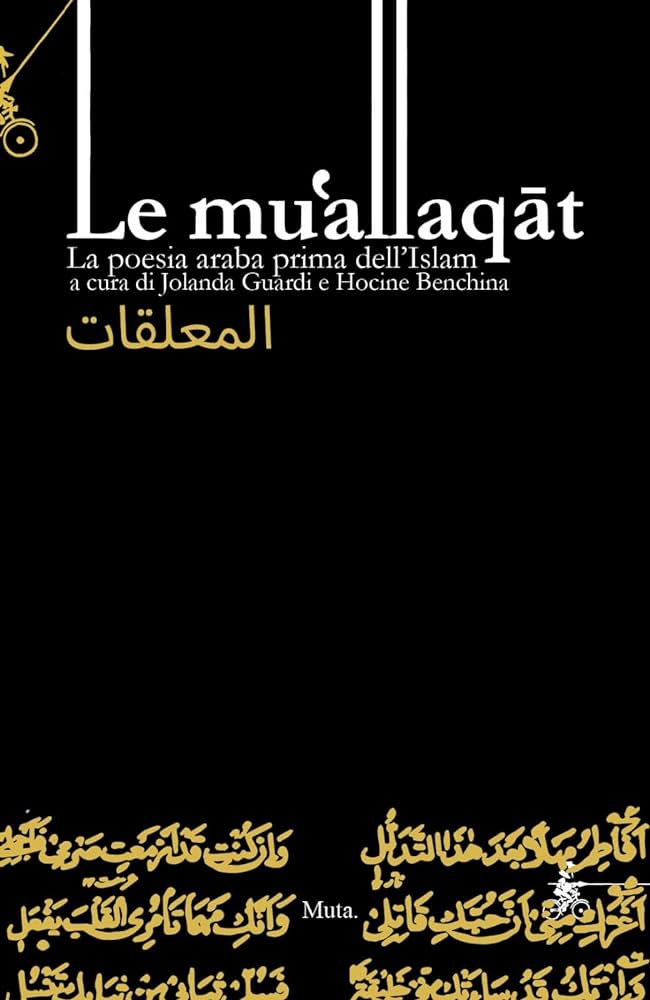
Oltre a "mu‘allaqāt" che pare significhi "le appese" in quanto erano esposte su stoffa o altro materiale, e che è un "termine che si ritrova per la prima volta nel Al-ğamhara aš‘ātr al-‘arab di Abū Zayd al-Qurašī (X secolo circa), infatti, " tali componimenti ritmici regolari "sono anche note come al-sumūṭ (fili di una collana) e al-muḏahhabāt (le dorate). Anche il numero delle poesie contenute nella raccolta varia a seconda dei recensori, da cinque a dieci, numero che viene proposto nella presente edizione".
Un grande poeta in lingua italiana del '900, Giuseppe Ungaretti, nato non a caso ad Alessandria d'Egitto, e quindi influenzato dai canti e dalle modulazioni di quella terra, parlava di se stesso e del poeta in generale come di un "nomade", condizione che accomuna questi poeti musaici e immaginosi, pur se gli studiosi, ci informa il libro, non separano più radicalmente tra sedentari e nomadi. Nomade è l'anima del poeta che sente comunque la vita come viaggio, come passaggio. Solo il poeta borghese contemporaneo pensa alla vita come immobilità, paresi, scavo puramente interiore di un pozzo della sua sensibilità. O meglio, è così il poeta borghese mediocre.
Molte altre cose si imparano leggendo questo manuale di poesia e antropologia e storia, a dimostrazione che la poesia è non solo espressione dell'animo profondo di un popolo o di epoche di popoli, ma anche la migliore sonda per conoscere quella vita e metterla in relazione ad altre, anche lontane nel tempo e nello spazio.
Il libro, tra antropologia, storia e poesia, ci illustra tanti aspetti della vita da cui sorgono queste voci meravigliose: lo stratificarsi delle popolazioni, le strutture tribali, il polidemonismo religioso, l'importanza dell'allevamento del dromedario e le evoluzioni legate, ad esempio, alla invenzione di una speciale sella. In tal modo, questo singolare libro, ci offre, insieme a quanto troviamo nei testi poetici come ambienti, metafore, dettagli finissimi, una immagine della ricchezza di vita da cui sorgevano queste voci che cantano l'amore, la nostalgia, la pena dell'anima. Ovvero le medesime esperienze, i medesimi abissi e tremori che emergono nella voce dei poeti di ogni tempo e ogni latitudine. L'anima e il cuore delle persone si somigliano sotto ogni cielo stellato di oriente e occidente. La vera globalizzazione non è quella forzata dei mercati, ma quella libera della poesia che nasce da cuori simili. La poesia mette a fuoco la vita ovunque. La conosce e la rende ardente e passa tale fuoco da bocca a bocca, da cuore a cuore. "Dio vomiterà i tiepidi", dice la Bibbia.
Sia che ci troviamo, secondo Ibn Rašīq, dinanzi al verso "migliore concepito da un poeta per la capacità di unire in un unico verso il tema del fermarsi, del piangere e del ricordo dell’amata e dell’accampamento", ovvero, paradossalmente, a un verso del "maledetto" poeta al Qays, che veniva chiamato "poeta diretto all’inferno", quello delle ulcere, poeta della vendetta, sia che invece ci troviamo dinanzi a un verso di potente evocazione come "La morte è nel respiro come il sole nel cielo", di Qiss ibn Sā‘ida al-Īādī, accade al nostro animo la meraviglia per una cosa così lontana e così prossima, così remota e così "riconosciuta". Paradosso della vita umana! Più la si conosce e la si indaga nella propria e nelle altrui culture, e più cresce il suo mistero.
Come in tutte le esperienze antiche e pure oggi - se pur in modo più disperso e direi cellulare - la poesia non aveva tra queste popolazioni un carattere privato, ma era segno per tutti.
"Riporta Ibn Rašīq: Quando in una tribù degli Arabi un poeta si distingueva, le altre tribù arrivavano per congratularsi. Veniva preparato il cibo e le donne si riunivano e suonavano i liuti proprio come facevano durante i matrimoni, mentre gli uomini e i ragazzi si scambiavano complimenti l’un l’altro; perché tale poeta rappresentava la difesa delle loro qualità, della loro discendenza, un rendere immortali le loro gesta e un’esaltazione del loro ricordo. Essi, infatti, gioivano solo per la nascita di un maschio, il distinguersi di un poeta tra loro o la nascita di uno stallone”.
Ed è sempre Ibn Rašīq ad affermare che "se si legge qualcosa nel Corano e non se ne comprende il significato, allora si deve cercarlo nella poesia preislamica, perché essa è l’archivio degli arabi".
E così dal prodigioso e polifonico lavoro di traduzione emerge lo scandalo e il cuore pulsante di ogni vero lavoro di traduzione. Tradurre non significa mai raggiungere un presunto "grado zero di differenza". La nota dei traduttori ne illustra bene la impossibilità. Non significa annullare la mia lingua nel cercare una imitazione più possibile legata a una fedeltà (presunta), bensì rendere ampia la ospitalità della mia lingua, della mia casa spirituale e artistica, per accogliere quella del testo tradotto. Una relazione ricca, libera, non un azzeramento. Una "verbis copula" dove, come diceva un inno antico, "stupet omnis regula". E che è patrimonio della poesia di ogni terra, quella di san Francesco santo e poeta della lode, della letizia cristiana e dell'Abissale Tu Altissimo, e anche di questi poeti dei beni, dei piaceri, delle malinconie. La traduzione come la poesia è un'arte in cui, nella unione amorosa delle parole, ogni regola non si annulla ma "stupisce". Così che possa accadere il prodigio dell'incontro, della ospitalità, quel che Ungaretti chiamava "fare la cosa delicata" e Giorgio Caproni chiamava salvare "il movimento dell'opera".
Dal gusto, dall'incanto, dallo stupore di stupori che ho vissuto leggendo questi testi e gli studi che li accompagnano, ricavo mille motivi per dire grazie a chi ha offerto questo lavoro.


